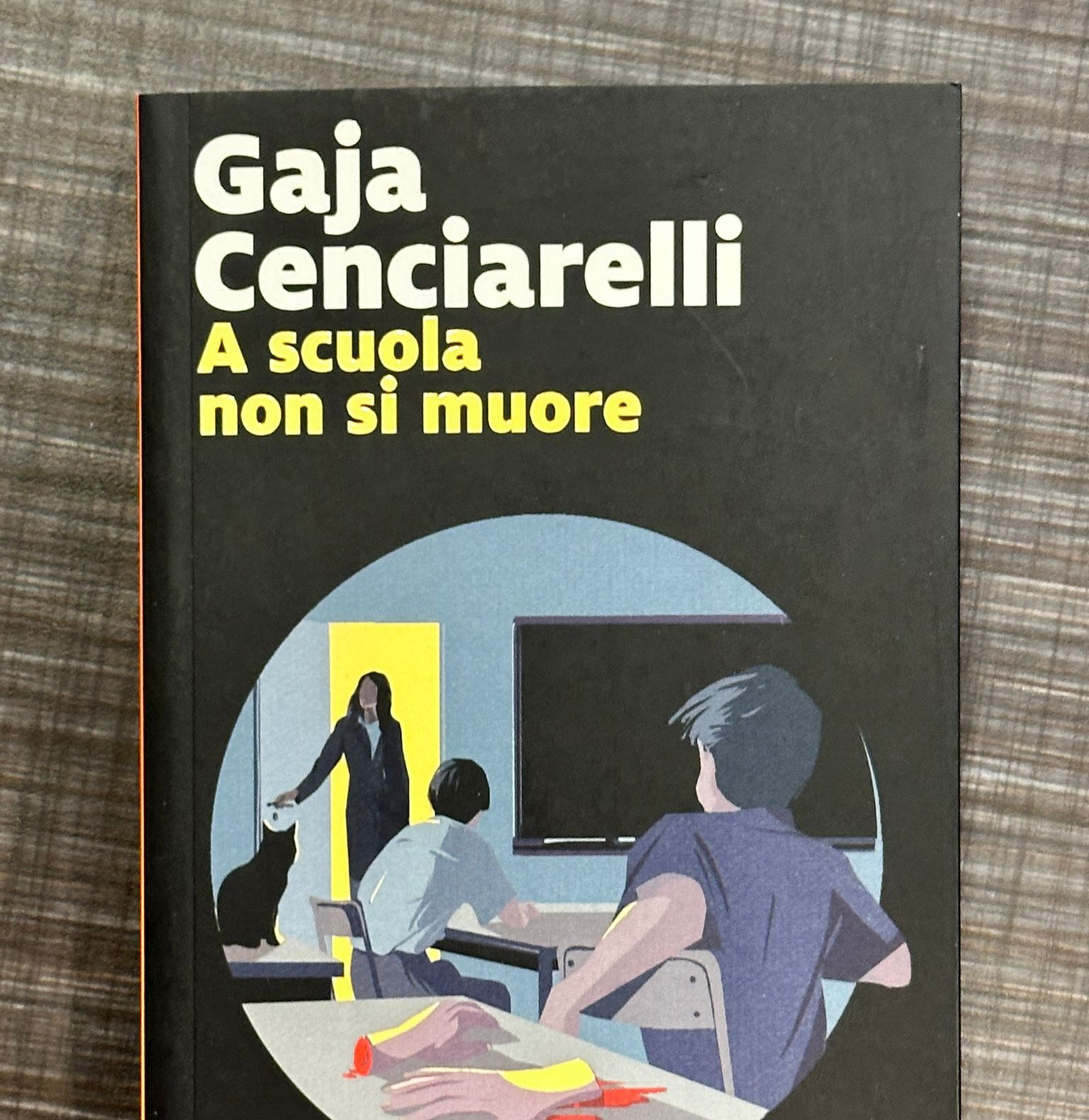di Sofia Liverani, II F
Vorrei iniziare con una domanda che concerne il titolo, “A scuola non si muore”. Ovviamente è ironico, perché è un giallo ambientato a scuola, però implica che a scuola si muoia?
“A scuola non si muore” è in realtà una ripresa del titolo di “A scuola si muore”, che è un’opera di Brunella Gasperini, grande scrittrice, troppo poco ricordata, che parlava delle morti a scuola e della scarsa sicurezza negli edifici scolastici. Possiamo dire che ho voluto fare questo omaggio a Brunella Gasperini, omaggio molto serio, in realtà, quanto sarcastico, perché c’è una crudeltà di fondo, perché a scuola che a scuola “non si muoia” non è vero, si muore eccome.
A chi consiglierebbe maggiormente il libro?
Agli studenti o ai docenti o agli esterni?Essendo io l’autrice, dovrei consigliarlo a tutti (ride, ndr.). Io penso che gli studenti lo sappiano bene, quello che c’è dentro la scuola, quindi non credo che siano i ragazzi che lo debbano leggere, anche se mi dà un’infinita gioia sapere che dei ragazzi lo hanno letto, non è paragonabile alla soddisfazione che posso avere sapendo che degli adulti abbiano fatto lo stesso. Credo che sia meglio che siano gli adulti che sono sia dentro che fuori la scuola, perché non sanno, o non si rendono conto. Sanno come funziona la macchina, sanno che esistono delle ingiustizie, delle disparità, lo sanno che esistono. Ma, diciamo, agli adulti a volte sfuggono le cose.
Colagrossi è un personaggio che viene presentato come ambiguo, all’inizio, e poi piano piano scopriamo sempre di più essere negativo. Perché ha voluto inserire l’iniziale amicizia tra la protagonista e Colagrossi?
Perché Margherita Magnani è ingenua, perché volevo descrivere subito così la personalità della Magnani, che è una persona che cerca l’amicizia sul posto di lavoro, non avendo ancora capito che in un ambito lavorativo di amicizie ce ne sono pochissime, rarissime e preziosissime; sicuramente lei non è una persona che coglie le doppie facce, le doppie vesti delle persone. Margherita si è fidata, è andata incontro a questa persona che le ha fatto un po’ da Virgilio, era il suo mentore, era quello che le ha insegnato tutto della scuola; pensava che lui la proteggesse. Li ho voluti amici inoltre per rendere ancora più grave lo strappo, l’offesa e l’insulto che Colagrossi aveva perpetrato ai danni di Margherita: non era stato un semplice collega, bensì proprio un amico ad averla ferita.
Una cosa che mi ha colpito è la sicurezza con cui Lei descrive la scuola. Si percepisce chiaramente che la vive, che Le sta profondamente a cuore, ma ciò a cui ho fatto più caso è che non si vede alcuna traccia di dubbio delle Sue convinzioni: già a pagina 2 si capisce che la protagonista ha certe idee e che attraverso tutta la storia non le cambierà nonostante le infinite critiche dei colleghi.
La Magnani non cambia semplicemente perché non ne è in grado. Lei conosce una via, si attiene a quella e fondamentalmente è convinta che sia quella giusta. Non è che non ci abbia provato, nella vita, a essere diversa, ci ha provato un sacco di volte, ha provato a fare come fanno tutti i bravi professori, a mettere un distacco, a cercare di non interessarsi troppo alla vita privata degli studenti e delle studentesse, ma non riesce, è più forte di lei. Margherita ha però visto che solo così riesce a dare il proprio meglio a scuola, non tanto ai ragazzi quanto a se stessa, e quindi è tornata indietro alle proprie convinzioni, abbandonando ogni indecisione. Di incertezze, per carità, ne ha; ha una sindrome dell’impostore che non ha fine, è convinta di non essere una brava insegnante, che i bravi insegnanti siano altri, però non riesce a essere altro che quello che è, tutto qua. Le conviene anche esserne convinta, perché altrimenti avrebbe una vita d’inferno.
Verso la fine del libro fa un excursus per parlare di normalità, scrivendo che la protagonista l’ha sempre inseguita invano. Sembra quasi che la si debba raggiungere, perché qualcosa di positivo, forse un giaciglio di sicurezza, però è irraggiungibile proprio perché inesistente. Allora perché cercare di raggiungerla?
Perché ci hanno illuso, perché ce l’hanno raccontato così, che ci sono i normali, che sono la maggioranza, e poi ci sono i diversi, quelli che non si omologano alla maggioranza; chi non si omologa è sempre additato, vedi come si veste, guarda come porta i capelli, guarda come si trucca, quello è troppo magro, quello è troppo grasso, è troppo basso, è troppo alto… È un modo per non sentirsi soli, è un modo per sentirsi uguali agli altri, che è il desiderio di tutti, ma è un desiderio irrealizzabile, perché la normalità non esiste. Il problema è proprio accettare il fatto che non esiste, che stiamo sempre rincorrendo questo ideale di volersi sentire uguali, di volersi sentire come tutti gli altri per non essere esclusi, per non essere rinchiusi in una parola: quello che ci spaventa sono le definizioni, che quasi sempre sono offensive. Moltissimi studenti me ne hanno parlato, di questa cosa, perché devi essere accettato, devi essere normale, ma non puoi, non puoi essere normale anche se non hai un PDP, una 104 o qualsiasi altra cosa. È proprio un concetto che dovrebbe essere scardinato dalla nostra società, e le linee guida che ci vengono fornite in quanto docenti non aiutano di certo.Adesso ne sta parlando per quanto riguarda gli studenti, nonostante il discorso tocchi moltissimo anche la professoressa Magnani.Certamente, perché la Magnani si mette nei panni degli studenti. Lei, forse, continua sempre a sperare di raggiungere la normalità perché c’è una parte estremamente nascosta di lei che ancora agogna di riuscire a essere normale: “anche io vorrei essere come tutti quelli che…”. Certamente. Vive però anche in un mondo che lo richiede, anche se, a mia memoria, le studentesse e gli studenti normali erano sempre gli altri. Certo non i miei amici. Chissà perché.